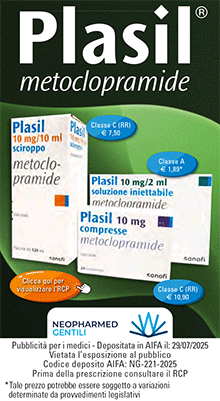Le allergie alimentari (Fa) si verificano tipicamente attraverso due percorsi mediatori: immunoglobulina E (IgE) mediato o non IgE-mediato, che si manifestano come fenotipi clinici distinti. Si ritiene che la forma più comune, Fa IgE-mediata, sia in aumento in prevalenza e gravità, in particolare in Europa occidentale.
Tuttavia, discrepanze nei dati autodichiarati e confermati dal medico e dal challenge alimentare orale (Ofc) portano a difficoltà nel quantificare la reale incidenza della Fa. Infatti, una recente revisione sistematica ha rivelato che la prevalenza di qualsiasi Fa diagnosticata dal medico e dall'Ofc era rispettivamente del 6.6% e dello 0.8%, mentre secondo i dati auto-riferiti era del 19.9%. Le differenze tra i tassi di allergia alimentare confermata clinicamente e autodiagnosticata sono state attribuite a fattori esperienziali, come reazioni psicosomatiche o associazione casuale del consumo di cibo con sintomi, ma anche a causa di diagnosi errate data la scarsità di servizi per le allergie. Queste complicazioni, insieme alle differenze nei tassi di Fa confermati dal medico e dall'Ofc, attestano come le differenze nella manifestazione della malattia e le sfide associate alla diagnosi possono oscurare i veri tassi di Fa.
Sebbene gli Ofc siano considerati il metodo gold standard per la diagnosi di Fa, sono anche dispendiosi in termini di tempo, denaro e comportano rischi potenziali per il paziente a causa della possibilità di reazioni allergiche. Pertanto, la diagnosi di Fa si basa spesso sulla combinazione di prick test cutanei (Spt) e livelli sierici di IgE allergene specifiche (s-IgE), insieme all'anamnesi del paziente. Tuttavia, i livelli di s-IgE e i risultati dell'Spt si basano sulla sensibilizzazione delle IgE, che non è necessariamente correlata alle manifestazioni cliniche di Fa. I test diagnostici Spt e s-IgE hanno una specificità da bassa a moderata e un valore predittivo positivo rispetto alle diagnosi Ofc, e sono stati attribuiti a sovradiagnosi. Inoltre, le s-IgE non sembrano essere in grado di predire la persistenza o la transitorietà della Fa, e possono essere utili solo in minima parte per prevedere la gravità dell'allergia e le conseguenti reazioni.
Di conseguenza, l’identificazione di una gamma più ampia di marcatori associati alla Fa non solo gioverebbe alla diagnosi, ma aiuterebbe anche i pazienti a gestire la loro allergia attraverso una maggiore comprensione delle sue manifestazioni. Inoltre, chiarire i meccanismi e i marcatori associati alla Fa aiuterà a scoprire gli effetti sistemici più ampi della malattia. Numerosi studi hanno descritto un'associazione tra Fa e sistema nervoso, rivelando una comunicazione bidirezionale tra mastociti e neuroni, in particolare all'interno del sistema nervoso enterico (Ens). Tali interazioni del sistema immunitario e nervoso nella Fa sembrano svolgere un ruolo nell'influenzare i sintomi sperimentati in seguito all'esposizione agli allergeni, così come ulteriori effetti comportamentali a valle. Tuttavia, le discrepanze in letteratura riguardanti la presenza e l'impatto delle interazioni neuro-immunitarie presentano una lacuna nelle attuali conoscenze.
A tal fine, una recente review si è posta l’obiettivo di valutare la ricerca sulle interazioni neuro-immunitarie nella Fa, nel contesto dell’attuale comprensione dei meccanismi immunitari della Fa. Esplorandola gli autori mirano a evidenziare l’importanza di comprendere tali processi per minimizzare gli effetti sistemici e ridurre il carico della malattia.
Bibliografia
Houghton V, et al. From bite to brain: Neuro-immune interactions in food allergy. Allergy 2024. DOI: 10.1111/all.16366
Intervista

Emicrania, le tappe per una gestione ideale
Cristina Tassorelli
Professore Ordinario di Neurologia
Università degli studi di Pavia