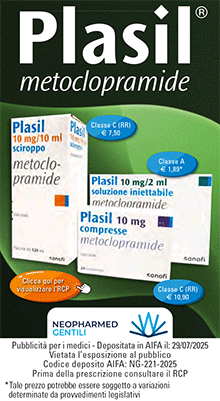Per molto tempo si è ritenuto che l'insulino-resistenza fosse il principale fattore eziologico dello sviluppo di diabete di tipo 2, ma negli ultimi tempi sta prendendo piede l’osservazione che questa non sia un difetto primario ma che si sviluppi secondariamente ad un aumento della massa grassa. In particolare, si svilupperebbe da un disequilibrio tra l'apporto calorico in eccesso e la capacità di immagazzinamento del tessuto adiposo, tanto da proporre la definizione di ‘diabete basato sull’adiposità”. Questo tema è stato al centro di uno dei simposi del 30mo Congresso Nazionale di Diabetologia (SID) recentemente conclusosi.
Spiega il Prof. Paolo Sbraccia, Direttore della UOC di Medicina Interna e Centro Obesità, Policlinico Tor Vergata e ideatore del simposio: “Credo che sia tempo che si passi ad utilizzare una classificazione patogenetica piuttosto che continuare ad utilizzare l’indeterminatezza di un numero (tipo 2). In inglese certamente utilizzerei la definizione che dà il titolo alla sessione (Adiposity-Based Diabetes), in italiano potremmo utilizzare il termine di diabete adiposo o diabete lipotossico. Certo è che le prove a favore di un’origine legata alla incapacità di immagazzinare appropriatamente l’eccesso calorico sono davvero soverchianti”.
“Uno dei punti si svolta si è avuto nel 1977 quando Rosalyn Sussman Yalow ha dimostrato che nel diabete di tipo 2 l’insulina era inefficace e non carente, scoperta che le è valso il premio Nobel’” prosegue Sbraccia “successivamente la corsa per scoprire i meccanismi alla base della resistenza ha lasciato indietro lo studio del tessuto adiposo. Lo avevano intuito anche Ippocrate e Morgagni, salvo poi cambiare direzione verso altre ipotesi. Ci riprovò nel 1947 Jean Vague che associò il fenotipo androide dell’obesità con lo sviluppo del diabete (ma anche con l’aterosclerosi e la gotta). Per tornare a parlare di grasso solo nel 1992, anno della scoperta della leptina, l’ormone responsabile del senso di sazietà e dell’aumento del dispendio energetico.
Gerald Reaven dimostrò che il 25% degli individui sani presenta un livello di assorbimento del glucosio, determinato dalla secrezione di insulina, sovrapponibile a quello delle persone con diabete di tipo 2 e che quindi un certo di grado di resistenza sia comune anche nella popolazione normale (ma con il rischio di sviluppare la malattia). L’intuizione proposta fu che la resistenza all’insulina precede la malattia e non il contrario. All’esatto opposto, la presenza di obesità e in particolare della circonferenza della vita, pone a favore dello sviluppo di Sindrome metabolica (o Sindrome X): la resistenza all’insulina, secondo questa tesi, sarebbe secondaria all’aumento della massa grassa”.
Si deve attendere il 1987 quando De Fronzo parla di ‘triumvirato’ alla base del diabete: la resistenza all’insulina a livello dei muscoli e del fegato più l’insufficienza delle cellule beta sarebbero i fattori responsabili della intolleranza glucidica nel diabete di tipo 2. Una triade a cui si sono aggiunti in seguito altri elementi: gli adipociti (lipolisi accelerata), il tratto gastrointestinale (mancanza/resistenza incretinica), le cellule-alfa (iperglucagonemia), il rene (aumento del riassorbimento del glucosio) e il cervello (insulino-resistenza) (De Fronzo et al, Diabetes 2009; 58: 773–95).
Altri studi, anche genetici, hanno individuato loci associati a fenotipi di resistenza all'insulina e 53 geni associati ad una capacità limitata di immagazzinare il grasso in modo corretto, rinforzando la tesi dell'insulino-resistenza come un segno secondario di un tessuto adiposo disfunzionale. Anche lo studio Epic ha permesso di dimostrare che i fattori modificabili come l'obesità superavano il rischio genetico nel conferire la tendenza a sviluppare diabete di tipo 2.
A ulteriore supporto anche gli studi sulla chirurgia bariatrica, che hanno permesso di osservare come poche settimane dopo l'intervento e molto prima della perdita di peso si determinava una notevole diminuzione dell'apporto calorico con cambiamenti metabolici che portavano a una inversione dell'insulino- resistenza.
“Questo simposio ha riacceso i riflettori su un tema cruciale per la comprensione e la gestione del diabete di tipo 2: il ruolo centrale del tessuto adiposo. Le evidenze presentate confermano quanto sia fondamentale ripensare al diabete non solo come una malattia del metabolismo del glucosio, ma come un disturbo profondamente legato alla disfunzione del tessuto adiposo. Questo concetto supera la tradizionale dicotomia tra soggetti magri e obesi, dimostrando come anche individui normopeso possano essere a rischio se presentano un'eccessiva quantità di grasso viscerale” dichiara il Professor Angelo Avogaro, Presidente SID, che aggiunge: “Queste nuove conoscenze ci spingono a rivalutare le nostre strategie terapeutiche. Se in passato l'attenzione era focalizzata principalmente sulla riduzione dei livelli di glucosio nel sangue, oggi sappiamo che è altrettanto importante agire sulle cause alla radice della malattia, ovvero sulla disfunzione del tessuto adiposo”.
Esistono quindi soggetti normopeso ma ‘metabolicamente obesi’ e individui obesi ‘metabolicamente sani’. I primi vedono un BMI inferiore a 25 ma una percentuale di grasso corporeo aumentata e un aumento della circonferenza della vita con depositi di grasso viscerale che li rende maggiormente suscettibili allo sviluppo di diabete di tipo 2. Non a caso l’obesità è associata ad un aumento della secrezione di insulina anche in assenza di insulino-resistenza. Queste nuove evidenze rafforzano il concetto del buon controllo dell’eccesso di grasso attraverso uno stile di vita sano in prevenzione e attraverso l’utilizzo dei nuovi farmaci per il controllo del peso.
Intervista

Emicrania, le tappe per una gestione ideale
Cristina Tassorelli
Professore Ordinario di Neurologia
Università degli studi di Pavia